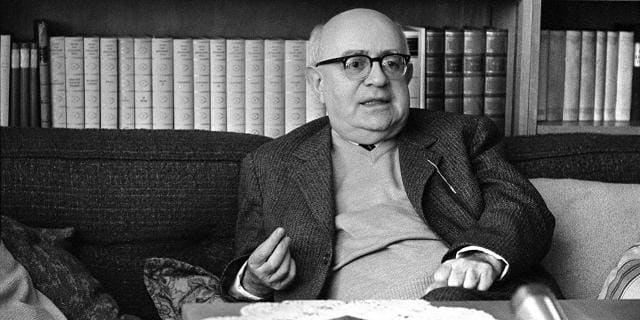La forma del saggio, è inevitabile, ha qualcosa a che fare con noi in quanto forma storica di un tempo che rifiuta il concetto medesimo di “oggettività”, che lo riporta in un orizzonte di soggettivismo che, subito, rende problematici gli assunti di partenza e, riflettendo sulle proprie stesse modalità di costruzione, inficia alla radice la sua meta, le sue conclusioni. La forma-saggio, la forma che si innesta sulle proprie solidissime aporie, voglio dire, ci rimanda come uno specchio l’immagine dell’intellettuale come a un tempo profeta e clown (e clown perché profeta, e viceversa), sempre ritratto nella luce ambigua del “secondo me”, cioè della scommessa interpretativa che ipostatizza gli assunti soggettivi e frammentari di partenza per scavalcare (come il balzo di Cavalcanti) gli steccati delle Estetiche e delle ideologie (scientiste o meno). In tal senso la forma-saggio è certo interpretabile come forma del liberalismo o dell’atomizzazione (dipende da come la pensiate politicamente; e ciò è normale perché la forma-saggio si costituisce anche in base al lettore) perché forma dell’individuo privo di comunità o, meglio, forma dell’individuo che nel saggio medesimo istituisce la propria comunità di riferimento, assolvendo a una funzione ideologica che, però, non si vuole sovrapersonale. Ma, come noi, il saggio è anche dogmatico, perché il suo intrinseco anti-dogmatismo (ciò che Ezio Raimondi definiva “la certezza irriducibile del molteplice”) vive quasi esclusivamente nelle ragioni della sua costruzione, e non in quelle della sua elaborazione. Non è vero che il saggio non includa una destinazione – come vorrebbero i critici scettico-liberali – ma è vero che tale destinazione vuole sempre essere compresa sul piano di un rimando ulteriore che potrebbe vanificarla.
Lukács, è ben noto, apre L’anima e le forme ragionando sul saggio quale forma che possa contenere la mobilità della vita. Si tratta di una forma in grado di racchiudere l’informe senza sclerotizzarlo: una forma che si caratterizza come tribunale al contempo arbitrario e ironico, sicuro di sé e aperto alle ragioni del proprio inevitabile fallimento. Ma Lukács, così facendo, non ci sta implicitamente dicendo che la forma-saggio deve andare anche al di là delle ragioni della propria stessa teorizzazione? Che un saggio… sul saggio è in qualche modo una contraddizione in termini? Che le ragioni stesse del movimento che il saggio ospita si modificheranno inevitabilmente nello sviluppo empirico dei saggi stessi? L’anima e le forme è certo un libro ironico, ma questa ironia dolorosa si applica al genere medesimo, e la libertà limitata e personale che il saggista avoca a se stesso, non è detto che si concluderà (è proprio ciò che avviene ne L’anima e le forme) nell’esaltazione, per dirla con Graham Good, di un sé che cambia in un mondo che cambia. O forse sì, ma nella coscienza che questo cambiamento potrebbe condurre alla dissoluzione delle stesse ragioni del genere saggistico.
Nel saggio sulla filosofia di Kierkegaard, Lukács dispiega tutte le caratteristiche del saggismo per inquadrare il lavoro di uno dei padri moderni del saggismo medesimo: la filosofia di Kierkegaard è spiegata nel quadro della sua relazione amorosa con Regine Olsen. Kierkegaard avrebbe improntato la sua condotta di vita allo scopo di fornire a Regine la trappola (la forma) con cui immobilizzare e portare a significato quel Proteo che è la vita. Ma come Kierkegaard tentò di fare ciò? Offrendo a Regine se stesso con le caratteristiche della forma-saggio: mobile, “capriccioso”, privo di meta, ecc. Ma tali caratteristiche, pertinenti appunto alla sfera del molteplice e dell’anti-dogmatismo, sono qui utilizzate da Kierkegaard a fini assolutamente dogmatici: Regine deve credere che quelle siano le caratteristiche che strutturano in modo assoluto la personalità di Kierkegaard, e solo mediante tale credo essa acquisirà una chiave di lettura, assoluta, del reale medesimo. Kierkegaard fallirà nel suo scopo. Regine comprenderà la complessa operazione e Søren non riuscirà ad elevare la sua vita a pura forma. Le ragioni della mobilità, della molteplicità, del non-concluso, avranno il sopravvento sulla loro forma assoluta (platonico-romantica) che Kierkegaard provò ad offrire a Regine, e la realtà dei valori del saggio si riverserà fuori dalla pagina.
Ma, e si comprende così quanto Lukács avesse davvero compreso la forza del saggismo, la forma-saggio che Kierkegaard ha sognato per sé, per sé come personaggio, si dissolve, e resta in quanto forma-saggio solo nell’operazione (nella forma) che Lukács medesimo compie su Kierkegaard. Ma se è così, perché il fallimento di Kierkegaard non dovrebbe già presupporre quello di Lukács come saggista? La forma-dialogica del penultimo saggio, quello non a caso dedicato a Sterne, già farà scadere il saggio (così esaltandolo) a strumento per schermaglie amorose (portare la forma-saggio, la forma del particolare di contro ad ogni universale, a parlare di un filarino adolescenziale significa esaltare il saggio o degradarlo?), e l’ultimo saggio del volume, Metafisica della tragedia, ridurrà il saggismo al silenzio dinnanzi alle modalità di un genere, appunto la tragedia, in grado di contenere in sé quella totalità che il saggio può presupporre solo in modo negativo. In tal modo, e così si comprende anche l’enorme distanza che separa Lukács teorico del saggio dall’Adorno impegnato nello stesso proposito, la verità del singolo, del particolare, che il saggio esprime, non sarà neppure più verità negativa di un’alienazione in corso, ma semplice ideologia, perché l’istanza anti-sistematica si farà, per ora, espressione ideologica di un mondo degradato e, fra qualche anno per Lukács, espressione ideologica della vita borghese, del rapporto inevitabilmente contemplativo (passivo e non agonistico) che il borghese instaura col reale.
Che si condividano o meno gli assunti dell’ungherese, dice Guido Mattia Gallerani nel suo ultimo volume, il saggio – come il romanzo lo è sul piano artistico – è la forma critica della “particolarità”. È anzitutto un sintomo del moderno, di quella caratteristica centrale della modernità che è il progressivo slittamento delle funzioni concettuali ed estetiche verso il contingente e il particolare, ad uno, inevitabilmente, con l’altrettanto progressiva decadenza degli stilemi interpretativi centrati invece sulle funzioni universalistiche pertinenti alla metafisica e all’ontologia classica. Il saggio ha qualcosa a che fare (sin da Montaigne) col decadere dei presupposti di una gnoseologia connessa ad un’idea di Verità, di un’etica connessa ad un Bene collettivo e comunitario, di un’estetica connessa ad un Bello che di quella Verità e di quel Bene sia partecipe. Il saggio pone in crisi la ragione concettual-sistematica offrendo un modello di conoscenza mirato a infrangere i modelli verticalistici di Verità, o, meglio, pronto a recuperare tali modelli solo all’interno di un presupposto individualistico (e in ciò è affine al romanzo), sottraendoli cioè al piano della loro socializzazione normativizzante.
Si tratta di un’operazione che, interna all’ideologia liberale borghese, ne esprime un’apparente auto-critica, perché delle astrazioni concettuali borghesi limita il campo d’azione, riconduce quelle a un orizzonte individualistico, e così facendo, al contempo (questa, crediamo, la verità più profonda del saggio), le demolisce e le esalta: le demolisce perché ne inficia le pretese di certezza, le riporta alla visuale personale del saggista, ma la esalta perché cosa può esprimere meglio l’epistemologia liberal-borghese se non proprio questa riduzione della verità alla prospettiva individuale, all’esperienza personale, allo stile personale? E cos’è lo “stile”, direbbe Fredric Jameson, se non la controparte letteraria dell’infrangersi delle ideologie di tipo comunitario che avevano caratterizzato il mondo pre-moderno? Tutta la prima parte del volume di Gallerani è dedicata, mediante una particolareggiatissima ricognizione delle riflessioni sul saggio, a squadernarne fenomenologicamente le caratteristiche: alle modalità della forma-saggio Gallerani risponde, verrebbe da dire, con un surplus di coscienza accademica, che ne riporta la totalità dei dati empirici e delle riflessioni teoriche: come a dire che se per il saggio, e per sua stessa natura, è possibile parlare solo ricavandone una teoria dalla totalità delle sue forme empiriche, allora solo la stessa ricognizione delle teorie sul saggio potrà condurci a intravedere la sua forma-empirica.
Dalle caratteristiche di tale forma, connessa, come detto, alle ragioni della personalità, della coscienza della natura arbitraria dello scritto, della consapevolezza del contesto contingente in cui la stessa scrittura saggistica si esprime, Gallerani muove poi a rivelarne quell’inevitabile corollario che si esprime nelle ragioni dell’eclettismo, della mescolanza e della contaminazione. Un genere, infatti, privo di un riferimento diretto a un sistema etico-ontologico di tipo sovrapersonale, sarà inevitabilmente un genere il cui “stile” non si avvertirà soggiogato da una forma fissa che a quelle strutture ideologiche sovrapersonali dovrebbe/vorrebbe riferirsi. L’istanza anti-sistematica (per dirla proprio con Adorno) che il saggio accoglie, lo conduce sulle vie non tracciate della profanazione dei generi, ed ecco che quella capacità del romanzo di inglobare in sé il saggio stesso (ottimamente tracciata da Stefano Ercolino in un suo libro recente) diventa qui – ed è lo stesso movimento, speculare e rovesciato – capacità del saggio di ospitare in sé modalità di scrittura differenti da quella critico-interpretativa, ciò che Gallerani definisce “pseudo-saggio” e descrive come “travestimento di un saggio critico sotto un altro genere” e come aggiunta all’argomentazione di “un’intenzione estetica”.
Tale intenzione, inevitabilmente, è sia parte di quella tensione al “particolare” che la forma-saggio ospita, sia nuovo reagente all’organizzazione stilistica del testo stesso, il quale, rifiutando una limitante sfera di competenza, continua a magnificare, mediante lo stile, quella centralità dell’individuo (quella relazione letteratura-vita) di cui si diceva in precedenza, facendo appunto della commistione il parallelo formale della epochè sull’approdo teorico-interpretativo generale. Da qui Gallerani ha buon gioco a tracciare, in un’ottica comparatista e sempre fenomenologica, la storia delle varie conformazioni dello pseudo-saggio (dialogico, biografico, romanzesco, “fantasmatico”, ecc.), anche prendendo talvolta in considerazione (sono soprattutto i casi di Sartre e di Barthes) l’incrociarsi delle forme saggistiche ai mutamenti storico-sociali, nonché il loro riferirsi (ma non è poi questa una possibilità implicita sin da subito nel saggio? Non è proprio ciò che capiterà a Lukács?) a strutture ideologico-filosofiche di carattere più vasto. In tali casi l’individuo monadico percorre a ritroso il cammino della forma-saggio: dalla totalità individualizzata, riconosciuta nella sua natura ideologica, può muovere nuovamente verso altre forme di ideologia. E in tal senso la riflessione di Gallerani sullo pseudo-saggio non solo aggiunge un fondamentale tassello alla ricognizione accademica su questa peculiare forma critico-interpretativa, ma pure ne mette in luce alcune potenzialità che il saggismo stesso, almeno nella sua variante scettico-liberale, vorrebbe inespresse.
Riferimenti bibliografici
G.M. Gallerani, Pseudo-saggi. (Ri)scritture tra critica e letteratura, Morellini, Milano 2019.
G. Lukács, L’anima e le forme, SE, Milano 1963.